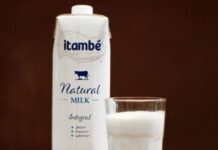Se è vero che l’invenzione della plastica è stata a dir poco rivoluzionaria per i grandi benefici che questo materiale ha apportato all’umanità in tutti i settori, è altrettanto vero che una produzione ed un consumo smodati dei materiali plastici hanno portato ad una delle catastrofi ambientali più disastrose degli ultimi anni.
Le proprietà che rendono la plastica un buon prodotto di mercato (come leggerezza, durevolezza, resistenza), tuttavia, la rendono anche inerte, dunque molto resistente alla degradazione. Questo ha comportato una sua diffusione ubiquitaria, infatti, ad oggi, la plastica può essere ritrovata praticamente in tutti gli ecosistemi e gli ambienti naturali, anche i più remoti ed impensabili. Studi recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche di polistirene nell’Oceano Antartico (Isobe et al., 2017) e tracce di microplastiche sono già state trovate persino nei tessuti e nelle escrezioni umane, inclusi polmoni, vie respiratorie, fegato, milza, placenta, colon, sangue e feci (Prata, J. C., 2023).
La plastica, ad oggi, è il terzo materiale prodotto dall’uomo più diffuso sulla Terra, dopo acciaio e cemento (Geyer R. et al., 2017). Tra le materie plastiche più richieste al mondo troviamo il polietilene a bassa densità (LDPE) e il polietilene tereftalato (PET) (Gewert et al., 2015; Plastics Europe, 2021), ampiamente utilizzate nella produzione di prodotti quotidiani come vassoi e contenitori o pellicole per imballaggio alimentare, nel caso dell’LDPE, e bottiglie o sacchetti nel caso di entrambi i polimeri.
I rifiuti di plastica sono oggi talmente diffusi nell’ambiente da essere stati suggeriti come indicatore stratigrafico dell’attuale nuova era geologica, contraddistinta dall’influenza delle attività umane: l’Antropocene (Gestoso I. et al., 2017). La maggior parte delle plastiche (90%) proviene da fonti fossili e nessuna di quelle comunemente utilizzate è biodegradabile, di conseguenza si accumulano nelle discariche o nell’ambiente naturale e, dopo una lenta disgregazione operata da fattori abiotici (sole, calore, umidità) e/o biotici (batteri e funghi), si trasformano in frammenti minuscoli, invisibili ad occhio nudo, chiamati microplastiche.
Seppur non esista un consenso scientifico sulla definizione di “microplastiche”, solitamente queste vengono definite come “frammenti di plastica di diametro inferiore a 5 mm”. In base alle loro dimensioni, possono essere ulteriormente suddivise in quattro categorie: microplastiche (< 0,5 cm), mesoplastiche (0,5-5 cm), macroplastiche (5-50 cm) e megaplastiche (> 50 cm) (Lebreton et al., 2018). Le micro e nano plastiche derivano non solo dall’immissione diretta nell’ambiente di prodotti che le contengono (microplastiche primarie), come cosmetici, pellets pre-industriali e prodotti per la pulizia, ma anche dalla frammentazione e degradazione dei rifiuti di plastica abbandonati in natura, dall’abrasione degli pneumatici, dall’usura dei freni o dal lavaggio di tessuti sintetici (microplastiche secondarie).
Le microplastiche sono difficili da digerire e da decomporre per gli organismi, il che comporta una loro diffusione lungo tutta la catena alimentare globale. Più un organismo è vicino alla cima della catena alimentare, maggiore è il suo contenuto di microplastiche e questo fenomeno mette seriamente a repentaglio la salute umana. Le microplastiche fungono da veri e propri serbatoi per sostanze chimiche nocive, come inquinanti organici persistenti (POP) e metalli pesanti (Shin e Choi, 2023), che possono attraversare i vari livelli trofici e causare fenomeni di bioaccumulo e bioamplificazione (da Costa et al., 2016).
Le tre principali vie di esposizione per gli esseri umani sono l’ingestione di alimenti contenenti microplastiche, l’inalazione delle microplastiche presenti nell’aria e il contatto cutaneo con queste particelle (Revel et al., 2018). La principale via di ingresso delle microplastiche nell’organismo umano è senza dubbio l’ingestione di prodotti alimentari contaminati, come prodotti agricoli e frutti di mare. Frammenti di microplastiche sono già stati segnalati in un’ampia gamma di prodotti alimentari, come cozze, pesce commerciale e sale da cucina, tra gli altri (Neves et al., 2015; Li et al., 2016). A causa della loro natura persistente, la loro rimozione dall’organismo è difficile e ciò può causare infiammazione cronica che aumenta il rischio di cancro (Kirstein et al., 2016; Revel et al., 2018). Molti degli effetti tossici sull’organismo umano, tuttavia, restano ancora sconosciuti e gli studi sono ancora in corso.

Nel 2023 il WWF ha stilato un report dal titolo “PLASTICA: DALLA NATURA ALLE PERSONE. È ORA DI AGIRE.”, nel quale viene presentato un quadro generale sull’inquinamento da plastica, con un approfondimento sulle sue conseguenze e sulle possibili soluzioni. Dal report emergono dati a dir poco allarmanti: basti pensare che il peso di tutta la plastica presente sul Pianeta ammonta a circa 8 miliardi di tonnellate, che equivale al doppio del peso della biomassa di tutti gli animali terrestri e marini presenti sulla Terra. A livello globale, solo il 9% di tutta la plastica prodotta viene riciclata e centomila sono le microplastiche che assumiamo potenzialmente ogni giorno attraverso cibo, aria e acqua. Inoltre, sono necessari dai 500 ai 1000 anni affinché le materie plastiche possano degradarsi.
I detriti di plastica sono stati trovati in tutte le coste, sulla superficie e nelle profondità di tutti i mari e oceani, nel suolo, nei laghi e fiumi, nell’atmosfera. Questo ha portato gli scienziati a poter dichiarare che esiste ormai un vero e proprio ciclo ambientale globale della plastica, al pari di quello del carbonio e degli altri elementi (Bank M.S. & Hansson S.SV., 2019; Zhu X., 2021.). Ogni anno vengono riversati nei fiumi, nei laghi e negli oceani di tutto il mondo da 9 a 23 milioni di tonnellate di plastica. Per quanto riguarda le immissioni nel suolo, le quantità sono molto simili ma si ipotizza che l’inquinamento terrestre da plastica possa essere persino superiore a quello marino. Studi recenti, infatti, avrebbero dimostrato che la quantità di microplastica nel suolo sia da 4 a 23 volte superiore a quella nell’oceano.
Nel report del WWF si legge che il nostro Paese è tra i peggiori in termini di inquinamento da plastica, tra tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nel Mare Nostrum si trova la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità marine, con 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato (Kane I.A. et al., 2020).
Il grande problema della plastica, come dicevamo, è proprio la sua persistenza. Secondo gli scienziati, la plastica sarà parte integrante della flora e della fauna selvatiche praticamente per sempre. Addirittura è stato scoperto un nuovo habitat microbico marino che si sviluppa sui detriti di plastica presenti nei mari, a cui è stato dato il nome di “plastisfera” (Amaral-Zettler L.A. et al., 2015).
Naturalmente, le conseguenze dell’inquinamento da plastica si ripercuotono sul clima, sull’economia e sugli esseri umani, e sono talvolta irreversibili. Le materie plastiche, durante il loro ciclo di vita, contribuiscono al 3,7% delle emissioni globali di gas serra (Landrigan P.J. et al., 2023). La maggior parte della plastica prodotta, infatti, deriva dal petrolio e dai suoi derivati e, quando viene incenerita, provoca ulteriori emissioni di CO2eq, oltre che di gas tossici e diossine cancerogene e mutagene, andando così ad aggravare il fenomeno del surriscaldamento globale. I danni economici includono i costi sanitari e quelli legati alla mancata erogazione dei servizi ecosistemici, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento negli oceani. I rifiuti di plastica, in particolare, causano ingenti perdite economiche dirette per i danni provocati alle imbarcazioni, agli attrezzi da pesca, al settore turistico e alle coste, che devono essere periodicamente pulite.
La plastica entra e si accumula anche negli ecosistemi terrestri a causa di uno smaltimento improprio, di espulsioni dalle discariche, di resti dei teli plastici utilizzati per la pacciamatura e di altre plastiche utilizzate nelle applicazioni agricole nei campi. Le microplastiche che si accumulano nei suoli ne alterano le proprietà chimico-fisiche e provocano effetti negativi sui processi biologici vitali delle piante e sulla pedofauna: gli animali del suolo, infatti, ingeriscono inavvertitamente queste particelle di plastica che causano effetti tossici come falsa sazietà, esaurimento energetico, crescita e sviluppo ostacolati. L’ingestione di microplastiche da parte degli animali del suolo, inoltre, influisce sul microbiota intestinale, sul metabolismo, sull’immunità e sulla fertilità. Le conoscenze sugli impatti della plastica sulla biodiversità terrestre, comunque, restano ancora molto limitate rispetto alle conoscenze sugli ecosistemi marini.

Senza un miglioramento nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti plastici, entro il 2050 la quantità totale di plastica potrebbe raggiungere i 25 miliardi di tonnellate (Back to Blue, 2021). Se accadrà, tra 30 anni nel mare ci potrebbero essere più plastiche che pesci (Ellen McArthur Foundation, 2017).
L’inquinamento da plastica è naturalmente un problema complesso su scala globale, al quale purtroppo, ad oggi, non esiste ancora una soluzione definitiva, nonostante la ricerca scientifica abbia fatto notevoli progressi negli ultimi anni. Le proposte per affrontare questa grande sfida ambientale sono già state vagliate e, in alcuni casi, attuate, ma è necessaria una loro condivisione e applicazione a livello globale, seguendo un approccio multilivello e multiattore. L’economia circolare potrebbe essere una delle possibili soluzioni, in quanto mira ad una gestione efficiente delle risorse, ad una minimizzazione dei rifiuti e dell’inquinamento e alla valorizzazione dei prodotti e dei materiali, mantenuti in uso per il maggior tempo possibile.
Come si evince dal report del WWF, le aziende hanno un ruolo chiave nel rendere circolari le plastiche, che devono essere facilmente riciclabili con indicazioni chiare che aiutino a favorire l’effettivo riciclo di questi materiali alla fine del loro ciclo di vita. Dal report, inoltre, emerge l’urgenza di un’azione coordinata a livello internazionale, che coinvolga i governi e le istituzioni di tutto il mondo in quanto l’inquinamento non conosce confini e mina il benessere e la salute delle persone di tutte le latitudini. Anche noi cittadini, naturalmente, abbiamo un ruolo di primaria importanza. In quanto consumatori, infatti, possiamo fare la differenza attraverso le nostre scelte e preferire l’acquisto di prodotti che non siano costituiti da materiali plastici o che siano comunque realizzati con polimeri di origine vegetale (bioplastiche), biodegradabili.
Bisogna fare attenzione però, in quanto non tutte le bioplastiche sono anche biodegradabili: il bio-polietilene, ad esempio, è un polimero vegetale, ottenuto dal bioetanolo sintetizzato a partire dalla canna da zucchero, utilizzato solitamente per flaconi di detergenti e cosmetici; questo polimero, anche se riciclabile al 100%, non è biodegradabile in quanto la struttura della sua molecola è praticamente uguale all’equivalente sintetico, dunque, se non viene riciclata e smaltita correttamente può accumularsi e persistere nell’ambiente esattamente come la plastica tradizionale. I polimeri vegetali biodegradabili sono in genere estratti dall’amido, dalla cellulosa o da oli vegetali. Tuttavia, anche questi polimeri, se trasformati eccessivamente, possono essere modificati in maniera tale da non essere più biodegradabili. La bioplastica può essere prodotta anche a partire da alcuni batteri, come quelli appartenenti al genere Pseudomonas. Batteri e funghi, inoltre, possono anche essere utilizzati per il biorisanamento di siti contaminati, in quanto producono enzimi particolari, capaci di degradare i polimeri che costituiscono la plastica in molecole più semplici, i monomeri, che utilizzano come fonte primaria di carbonio per accrescersi e moltiplicarsi.
Insomma, le alternative più ecologiche e sostenibili esistono e possono già essere trovate in commercio. Sta a ciascuno di noi documentarsi, smaltire correttamente i rifiuti e scegliere di essere parte attiva ed integrante della soluzione. Siamo davvero pronti a rivoluzionare le nostre abitudini e il nostro stile di vita per tutelare il Pianeta e, di conseguenza, noi stessi?